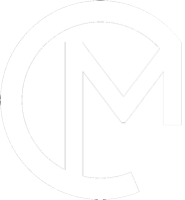La storia socioeconomica di Cremona romana si riflette in modo significativo sulla sua edilizia, sia pubblica che privata. Quella pubblica rappresenta l’espressione di quanto l’autorità politica vuole manifestare ideologicamente, non solo a livello locale ma anche nei confronti di Roma; quella privata è tesa a sottolineare il prestigio delle élites tra i propri pari e verso i clientes.
Non esistono dati sulle abitazioni delle primissime fasi della città, anche se si può pensare a semplici strutture in legno e terra, con pavimenti in terra battuta e tetti in erbe palustri.
Della seconda metà del II secolo a.C. abbiamo l'importante testimonianza della domus di via Colletta, con un bellissimo pavimento in cocciopesto decorato e muro recante ancora sulla faccia interna parte della decorazione dipinta.
Intorno alla metà del I secolo a.C., il rinnovamento dell’edilizia privata è testimoniato da ritrovamenti di domus con pavimenti ancora in cocciopesto, mentre solo in età protoimperiale si afferma l’uso di mosaici, di affreschi raffinati, di elementi architettonici in pietra, di spazi aperti colonnati, di giardini con statue e arredi marmorei, di ninfei.
Nel II secolo d.C. si prediligono ambienti absidati e pavimenti musivi policromi con complessi giochi geometrici. Gli intonaci dipinti sono l’unica testimonianza superstite del periodo tra la fine del III e l’inizio del IV secolo d.C.
LA DOMUS DEL NINFEO
Molti reperti presenti a museo provengono dallo scavo dell’attuale piazza Marconi dove si trovava la domus del Ninfeo: un esempio eccezionale della complessità planimetrica che potevano raggiungere le abitazioni private.
La domus occupava metà dell'insula urbana (m80 x m80), sviluppata, con forte impatto scenografico, su più livelli terrazzati e distribuita intorno a spazi aperti colonnati, due dei quali accoglievano giardini con grandi vasche d’acqua e un ninfeo monumentale. Al piano superiore si accedeva ai cubicula e al triclinium, con affaccio panoramico sul fiume Po, mentre al piano terra si trovavano le cucine, le dispense e gli altri ambienti di servizio.
Alcune delle stanze o i portici che si affacciavano sul giardino erano a loro volta affrescati con raffigurazioni di arbusti, fiori e uccelli.
Il giardino era il centro della casa, luogo ameno dedicato all’otium. Questo spazio era ideale per lo sfoggio dello status del padrone di casa, con gli spettacolari giochi d’acqua in vasche e fontane.
Nel corso della bella stagione era d’uso cenare presso il ninfeo allietati dalla frescura e dalla suggestiva ambientazione.